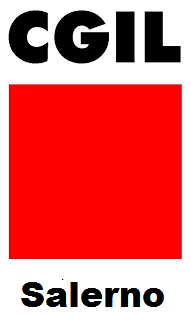(“La città di Salerno”, 12 giugno 2014, p. 45)
La morte di Enrico Berlinguer, trent’anni fa, ha senza dubbio assunto un che di eroico, proprio del gesto di chi, pur avvertendo la pena e l’affanno di vivere, continua nella sua azione, con la disperata tenacia che solo la completa dedizione alla propria missione può generare. Così almeno l’hanno vissuta milioni di italiani, di ogni generazione, che al dirigente comunista erano legati da vincoli “di parte”, ma anche, allora, da chi era lontano politicamente dal segretario del PCI. Ancora maggiore interesse suscita l’attenzione che, dopo tre decenni, è riservata alla figura di questo sardo minuto e schivo, che tutti dicevano triste, e che, invece, compostamente viveva il suo ruolo di capo del piú grande partito comunista dell’occidente. Una attenzione non limitata ai giovani di allora, ma che coinvolge tanti che nel 1984 non erano ancora nati. In un mondo che prende a misura di tutte le cose i “follower” o i “mi piace” e che poco tempo dedica alla cultura e alla passione politica forse sorprende che il profilo facebook su Enrico Berlinguer abbia quasi 450 mila “mi piace” e che il sito www.enricoberlinguer.it sia partecipato da migliaia di persone. Entrambi sono stati creati e gestiti da Pierpaolo Farina, milanese di madre napoletana, classe 1989: uno che Berlinguer lo ha conosciuto dai racconti paterni e dalle immagini conservate in rete, ma che soprattutto lo ha incontrato negli scritti su “Rinascita” o su “l’Unità” o nei libri a lui dedicati.
È significativa la motivazione che Farina pone alla basa del perché ha deciso di costruire il sito e il profilo facebook: «Restituire il ritratto di un uomo politico – la cui eredità rimane in larga parte ancora viva e attuale – a tutti i giovani che, come noi, sono nati dopo la caduta del Muro di Berlino e che, nel desolante orizzonte politico, culturale e ideale odierno, fanno fatica a individuare un esempio da seguire, un punto di riferimento cui aggrapparsi» (Farina 2014). Chiaro, assolutamente chiaro.
Ma quali possono essere i temi che oggi sono capaci di attrarre i giovani verso una figura “d’altri tempi”, che per intero appartiene al mondo delle tanto vituperate “ideologie” e che, per di piú, non ha mai smesso di essere, dirsi e vivere da comunista, sia pure occidentale e italiano?
Paolo Mieli, a conclusione di uno speciale su Berlinguer trasmesso in questi giorni da Raistoria ha evocato la questione morale. È vero, è uno dei temi essenziale dell’ultimo periodo della vita politica del dirigente comunista: un vero e proprio cruccio, un tormento pressoché quotidiano. Non credo esclusivamente in funzione antisocialista, anche se note sono le critiche al craxismo, né al solo sistema di potere della Democrazia cristiana. Berlinguer avvertiva un pericolo piú generale di imbarbarimento della vita politica, quasi un passaggio dai “politici di professione” a coloro che, per vivere bene, avevano scelto di dedicarsi alla attività politica. Dei primi egli stesso era pienamente espressione, essendosi «iscritto giovanissimo – come disse Giancarlo Pajetta – alla direzione nazionale del PCI» –, ed essi avevano dedicato la propria esistenza al servizio di una causa ideale e che per questa scelta avevano pagato con il carcere, il confino, l’esilio e spesso con la morte durante la dittatura fascista, ma che vivevano una condizione non certo agiata anche durante la posteriore vita repubblicana. È il mondo di De Gasperi presidente del consiglio con il cappotto rivoltato che condivide con altri un unico appartamento romano; dei dirigenti comunisti e socialisti che giravano un Mezzogiorno affamato e dolente, ospiti delle povere case dei contadini con i quali dividevano il cibo, dei quali erano “compagni” nel senso etimologico e piú teneramente umano del termine. I secondi, professionisti della politica, hanno negli ultimi decenni piegato la politica alle proprie condizioni economiche e sociali, passando da un partito all’altro – ma i partiti non erano finiti, sepolti dalla rovine del muro di Berlino? – e da un consiglio di amministrazione a una carica elettiva a un posto di assessore senza perdere un turno, salvo poi, in tanti, come in un enorme Monopoli, ad andare in galera senza passare per il via.
Già, la questione morale, allora, che è questione politica, ma è questione culturale.
Ma come non pensare alle straordinarie manifestazioni per impedire l’installazione dei missili a Comiso e per fermare la corsa agli armamenti; come non legare indissolubilmente il nome di Enrico Berlinguer ad una straordinaria stagione di iniziative per la pace. “Battaglie” perse, ma che andavano “combattute”, per usare termini militaristi. È la realtà odierna, le crisi “regionali” che si aprono sempre piú spesso, l’accavallarsi di guerre anomale, asimmetriche, falsamente ammantate di motivazioni religiose che ci dicono quanto la sconfitta allora delle idee di Berlinguer – e di quei giovani che in piazza esaltavano il “carrarmato Perugina” contro tutti gli strumenti di morte – sia oggi alla base di un mondo piú insicuro, piú violento, meno giusto e che la fine del male assoluto, l’Unione Sovietica, abbia determinato l’esigenza di nuovi nemici, nuovi stati canaglia, altri obiettivi da perseguire e perseguitare.
Ma Berlinguer non è stato solo questo. E non mi riferisco tanto al compromesso storico, una stagione politica complessa e non priva di limiti, ma che, ancora una volta, poneva già negli articoli del 1973 su “Rinascita” l’esigenza di unire le forze popolari contro i pericoli di rigurgiti neofascisti. Né voglio rievocare lo spettro dell’eurocomunismo.
Mi riferisco, piuttosto, a un tema troppo spesso espunto, quello dell’austerità. Lo definisce in due discorsi a gennaio del 1977, per i quali sceglie due “interlocutori” particolari e significati: gli intellettuali, a conclusione del loro convegno a Roma il 15 gennaio, e gli operai comunisti, a conclusione della loro assemblea a Milano il 30 dello stesso mese. È un tema che ha attirato su Berlinguer la facile ilarità di chi lo definì pauperista, francescano – anche se un altro Francesco, oggi, dice cose non dissimili – nemico del benessere capitalista. Cosa voleva dire Berlinguer? Due facili questioni, per chi avesse voluto intendere. La prima di merito: l’austerità è «una scelta obbligata e duratura, e che al tempo stesso, è una condizione di salvezza per i popoli dell’occidente […] ma, in modo particolare, per il popolo italiano». E una seconda di metodo: «l’austerità è il mezzo per contrastare alle radici e porre le basi del superamento di un sistema che è entrato in una crisi struttura e di fondo, non congiunturale, di quel sistema i cui caratteri distintivi sono lo spreco e lo sperpero, l’esaltazione dei particolarismi e dell’individualismo piú sfrenati, del consumismo piú dissennato».
Oggi, a trent’anni di distanza, quegli stessi soloni che allora dissero che Berlinguer sbagliava perché era contro il progresso, ci ripetono ora che abbiamo vissuto per anni sopra le nostre possibilità e che ci tocca stringere la cinghia, fare sacrifici.
Ecco, queste sono forse alcuni dei temi che inducono i giovani a conoscere Enrico Berlinguer, ad avvicinarsi al pensiero di un uomo schivo e tenace. Quel che davvero rammarica è che essi sono soli ad effettuare questa riscoperta e le istituzioni culturali, dalla scuola all’università – i partiti non contano, non esistono – sono girate da un’altra parte.
Peccato.